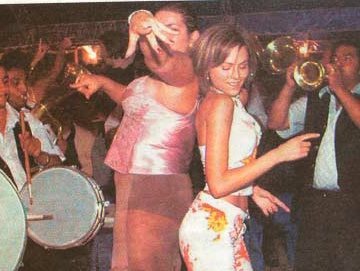A Guca, villaggio nella Serbia centrale, il festival annuale di musica rom e tradizionale. L’energia di ottoni e grancasse, le centinaia di maialini allo spiedo ed una Serbia ambigua, che non si guarda in faccia e s’aggrappa ancora alle effigi di Karadzic e Mladic
Ottoni a scoppio
di Davide Sighele
Una bambina rom gira con una fisarmonica di cartone. Le sue dita si muovono sui tasti disegnati con un pennarello. Fa solo finta di suonare, per chiedere l’elemosina, ma tutt’intorno la musica tuona. Vicino a lei alcuni ragazzi s’arrampicano su di una grande statua di bronzo, fin sopra la folla che s’accalca nella piazza. Uno di loro alza pollice indice e medio al cielo, le tre dita simbolo della trinità ortodossa ed urla “Srbija, Srbija”. Poi mostra la maglietta con il viso di Karadzic; un altro ragazzo al suo fianco, dopo essersi issato fin quasi alla tromba che il musicista immobile da anni alza verso il cielo, si infila due palloni sotto la maglietta ed orgoglioso di questa nuova prosperità abbozza, con un equilibrio precario, qualche passo di danza.
A poche centinaia di metri un’altra piazza, più piccola. Fino a lì, ma anche in tutte le vie attorno, è una teoria senza fine di bancarelle e ci si fa strada a fatica. Al centro della piazza una chiesetta ortodossa. Bianca. Sulle facciate una lunga lista di nomi, soldati serbi caduti durante la prima guerra mondiale. Al fianco del portone centrale una bancarella. La controlla un uomo alto, sulla quarantina, pantaloni militari stretti alla vita, felpa nera e berrettino da baseball anch’esso nero. Si muove un po’ impacciato, forse si vergogna di essere finto a fare il bancarellaro lui che forse ha fatto parte di quei gruppi paramilitari al fianco dei fratelli serbi in Croazia, Bosnia e Kossovo. Ora si deve accontentare di vendere spille e magliette raffiguranti gli “eroi nazionali” Karadzic e Mladic, croci ortodosse e berretti cetnici, circondato da suonatori rom. In un angosciante “mercato del tempio”.
Questa piccola piazza è il cuore di Guca, villaggio nella Serbia centrale, 150 km a sud di Belgrado. Ogni anno vi si tiene un noto festival di musica tradizionale. Oltre quaranta gruppi da tutto il Paese si ritrovano qui e Guca passa dal suo qualche migliaio di abitanti che vi risiedono abitualmente ad accogliere, nel giro di un fine settimana, più di 300.000 persone. Che pesano tutte sulla piccola piazza della chiesa: la gente pigia per passare e ci si ritrova nuovamente a camminare. Tutt’attorno i colori forti dei tendoni con centinaia di tavoli e sedie. Li lambisce il fumo denso degli enormi bracieri che respirano come polmoni. Su lunghi spiedi continuano a girare per tutti i tre giorni di festival maialini e capretti.
I loro occhi quasi a scrutare i passanti, oramai senza curiosità e sofferenza ma con la tragicità del corpo allungato ed inerte. L’odore forte della carne si mescola a quello più acido dei cavoli che vengono lasciati per ore a cuocere in enormi giare di argilla, anch’esse adagiate sulle braci.
E tutto sembra quasi fatto a posta, per creare l’ambiente adeguato alla musica. Il giallo opaco degli ottoni catalizza ogni sguardo e non tradisce le sintonie che ne escono. Calde e potenti, solo a tratti più strazianti ma riportate in fretta ad un esuberante allegria dall’incalzare di rullante e grancassa. Il viso scuro dei musicisti rom, dai lineamenti decisi, si esprime di pari passo agli strumenti, secondo un rituale che si respira antico. E le ammaccature su trombe, bassi tuba e bombardini ricordano che questa è musica da strada. Che gli strumenti riposano solo per qualche ora, le prime dell’alba, ammassati in furgoncini Volkswagen; i musicisti, se è bel tempo, dormono all’aperto su materassi di gommapiuma. Altrimenti tutti dentro, con i finestrini per cuscino, prima di ricominciare a suonare.
Questa è la musica che abbiamo conosciuto con i film di Kosturica e grazie a Goran Bregovic. Qui a Guca però la si capisce meglio. Non è solo un simbolo di sfrenata libertà, di indole goliardica ed irruente. E’ anche la colonna sonora di una precisa scala sociale che vige oggi in Serbia.
Ad un tavolo il capofamiglia, un uomo sulla sessantina, chiama con tono complice uno dei componenti di una banda. Gli infila dei soldi in tasca e quello allora fa segno agli altri di avvicinarsi. Si dispongono, facendosi spazio, tutt’intorno. Poi il musicista toglie la banconota dalla tasca, la inumidisce con un po’ di saliva e se la incolla in fronte. E’ il segnale per iniziare a suonare. L’apertura degli ottoni, un vuoto dolce e buio, s’allarga proprio sulle orecchie di chi ha pagato. Che se ne sta immobile, compiaciuto di “possedere” una banda. Ogni tanto un’indicazione ai musicisti. Altri dinari, altre canzoni. Sino a quando la banda si sposta chiamata da un tavolo vicino. La scena si ripete centinaia di volte e spesso a pochi metri di distanza suonano contemporaneamente più gruppi, in un’orgia di sonorità.
Ma ai tavoli non siedono mai rom. Emarginati e discriminati dalla società serba, neppure qui a Guca, loro che sono la vera anima di questa musica, sono protagonisti. Sembrano piuttosto comprimari. Suonano per i serbi che li pagano e li acclamano. Ma nell’iconografia della festa rimangono sempre su un gradino inferiore. Il rituale è chiaro: chi paga comanda e sotto i tendoni di Guca si ripete questo cerimoniale di dominio che ha la forza della tradizione.
Ancor più sotto, in un’ipotetica piramide sociale che Guca mette prepotentemente in rilievo, vi sono le danzatrici. Alcune di loro giovanissime. Sembrano appartenere tutte allo stesso gruppo. Sono arrivate su due vecchie Mercedes e la notte dormono riparate dal rimorchio che trasporta gli autoscontri del luna park. Girano per i tendoni, danzano vicino ai tavoli in modo sensuale, i vestiti lunghi, il ventre scoperto. La loro bellezza è già prematuramente affaticata. A volte si strusciano su chi è seduto in un abbozzo di lap dance. Per qualche dinaro. Qualcuno più arrogante di altri chiede loro di avvicinarsi, apre loro le labbra e controlla i denti. “Questa ne ha cinque d’oro” urla ridendo poi sguaiato verso gli amici. I musicisti a volte le accettano al proprio fianco, altre le mandano via perentori. Basta uno sguardo od un colpo deciso della mano e loro s’allontanano accennando ancora a qualche mossa. Si perdono nella folla per poi riapparire a qualche altro tavolo.
Ma il festival di Guca è interessante anche per comprendere dove sta andando la “nuova Serbia” del dopo-Milosevic. Allontanandosi dal cuore “più tradizionale” del festival, lasciando le tre vie centrali del villaggio, la folla non diminuisce ma aumentano i giovani. Alla sera occupano ogni spazio, riempiendolo di birra e di sudore. Molti di loro, bandana e nike, ballano il kolo, danza tradizionale serba. L’abbinamento stupisce. Tutt’intorno altri maialini allo spiedo, pistacchi, tritacarne e pantofole di plastica. Lungo le strade più marginali si vende infatti di tutto, comprese le fotografie di Karadzic e Mladic. Molti i ragazzi che vi si fermano davanti. “Sono un vero serbo”, “Karadzic e Mladic eroi nazionali” si legge su alcune magliette. Simboli molto nazionalisti, che non tutti indossano ma che sembrano accettati con tranquillità e normalità.
Quella di Guca è una Serbia che sembra non essersi mai guardata in faccia. Che si sente “nuova” senza mai essersi pensata nuova. E’ la Serbia più viscerale, in parte quella che in questi anni ha mescolato con molta disinvoltura musica tradizionale, mafia, kalashnikov e rakja, la grappa locale. La Serbia non è solo Guca, qui accorre il pubblico ancora legato al connubio perverso tradizione-nazionalismo che Milosevic ha cavalcato negli anni al potere. Ma la Serbia di oggi è anche Guca, insieme vitale e sterile come la sua musica.
Pensieri che emergono nelle poche pause concesse dal festival, alle prime ore dell’alba. Quando il fumo delle braci smette di imbiancare il cielo. Una vecchina s’aggira tra le bancarelle coperte da teloni, attenta a non incrociare i passi barcollanti dei reduci dalla lunga nottata. Quasi sussurrando pronuncia la parola “Kafa”, caffè. E se qualcuno si avvicina apre la borsa di stoffa che porta al braccio e tira fuori un thermos. Qualche dinaro per un sorso. E’ il suo modo di integrare la misera pensione riservata agli anziani in questo Paese. Solo che il festival arriva a Guca solo per tre giorni all’anno, mentre il pane serve ogni giorno. Pensieri che mi riportano alle parole di Danjela, studentessa di archeologia a Belgrado: “No, a Guca non posso venire. Mi mancano i soldi dell’autobus. Sai, qui in Serbia non è ancora cambiato nulla. Ci vorranno almeno vent’anni. Troppi. Abbiamo già aspettato abbastanza, noi giovani vogliamo tutti andarcene”.
E la folla che s’accalca a Guca sembra quasi essere perenne passeggera dell’enorme giostra situata nell’immediata periferia del villaggio. Tutti a girare nell’aria su seggiolini di metallo e plastica colorata. Liberi e prigionieri. Sino al prossimo gettone.
L’evento
Il Dragacevski sabor, l’annuale festival internazionale degli ottoni, si svolge i primi giorni di agosto
Per informazioni: www.guca.co.yu
Senza categoria