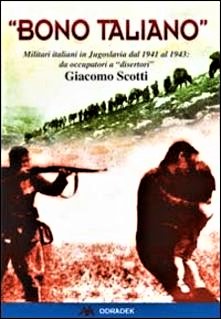“Una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome” (Talmud)
Giovedì 21 gennaio “Viaggiare i Balcani” è stato presente alla cerimonia di posa di quattro “pietre d’inciampo” a Padova.
Le pietre realizzate nel laboratorio dell’artista tedesco Gunter Demnig e collocate in quello che un tempo era il Ghetto ebraico – nel cuore della città -, sono dedicate alla memoria di Celina Trieste, Ester Giovanna Colombo e Guido Usigli.
A un passo dalla Basilica di Sant’Antonio è stata poi onorata la memoria di Padre Placido Cortese, a cui è dedicata la quarta pietra d’inciampo. Nato a Cherso, isola dell’Adriatico orientale, il giovane frate francescano si era adoperato a favore dei prigionieri sloveni e croati in vari campi d’internamento – tra cui quelli di Chiesanuova di Padova e Monigo di Treviso -, per la fuga di prigionieri alleati e per la salvezza di uomini e donne ebrei. Tradito e arrestato nell’ottobre 1944, morirà il mese successivo per le sevizie senza risparmio subite nella sede della Gestapo di Trieste.


Di queste quattro vittime, la cui memoria diventa parte della città grazie anche all’iniziativa e al sostegno del Comune di Padova, riportiamo qui sotto dei brevi testi biografici delle prime tre e l’epilogo della vita di Padre Cortese. Sono stati letti durante la cerimonia di commemorazione, che porta a 28 le pietre d’inciampo presenti nella Città di Padova.
Vale la pena far precedere questi testi da una piccola nota sulle pietre d’inciampo ricavata dal sito www.pietredinciampo.eu. Questi “micro memoriali”, parte di una fitta rete di migliaia di identici memoriali diffusi in larga parte d’Europa capovolgono la logica del piano di sterminio nazista. Se con l’assegnazione di un numero che accompagnava sempre e dovunque ciascun internato (fatto testimoniato dalle parole dure e asciutte di Liliana Segre) si mirava alla spersonalizzazione e all’annientamento dell’identità, con la pietra d’inciampo si riacquista la dimensione dell’individuo grazie a tre pilastri fondamentali della vita di ogni persona: il nome e il cognome, la data di nascita ed il luogo in cui si abita.
ALCUNI CENNI SULLE PIETRE D’INCIAMPO
“Un piccolo blocco quadrato di pietra (10×10 cm), ricoperto di ottone lucente, posto davanti alla porta della casa nella quale ebbe l’ultima residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti. Ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000. La prima a Colonia, in Germania, nel 1995. Sono le “Pietre d’Inciampo” (Stolpersteine in Tedesco): iniziativa creata dall’artista Gunter Demnig (nato a Berlino nel 1947) come reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, al fine di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, perseguitate per qualsiasi motivo: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali.
Grazie a un passaparola tanto silenzioso quanto efficace, oggi si incontrano Pietre d’Inciampo in oltre 2.000 città in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Ungheria.
In Italia, le prime Pietre d’Inciampo furono posate a Roma nel 2010 e attualmente se ne trovano a Bolzano, Genova, L’Aquila, Livorno, Milano, [Padova], Reggio Emilia, Siena, Torino, Venezia, oltre ad altri numerosi centri minori.
Per spiegare la propria idea, Gunter Demnig – che posa personalmente le Pietre d’Inciampo – ha fatto proprio un passo del Talmud: “Una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome”. Obiettivo della Pietra d’Inciampo – un inciampo emotivo e mentale, non fisico – è mantenere viva la memoria delle vittime dell’ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo della vita quotidiana – la loro casa -, invitando allo stesso tempo chi passa a riflettere su quanto accaduto in quel luogo e in quella data, per non dimenticare”.

A CHI SONO DEDICATE LE 4 PIETRE D’INCIAMPO
Via S. Martino e Solferino
Ester Giovanna Colombo, nata a Padova il 9 marzo 1927, abitava in via S. Martino e Solferino 13, con il padre Ferruccio. Portava il nome della nonna paterna Giovanna Sattin, ariana. Grazie all’arianità della madre, Ferruccio Colombo, inizialmente arrestato e internato a Vo’, era stato rilasciato il 9 febbraio 1944, come “appartenente a famiglia mista”. Propriamente, secondo i criteri di classificazione razzista, anche sua figlia non sarebbe stata da considerarsi ‘di razza ebraica’: essendo nata da padre ‘misto’ e da madre ariana, era di fatto ebrea solo per un quarto. Ma i suoi genitori non erano sposati e la mamma, Maria Boaretto, non l’aveva riconosciuta alla nascita, e inoltre Ester Giovanna era cresciuta nella religione ebraica. Dopo essere vissuta per qualche tempo a Venezia, fu arrestata con una zia il 2 dicembre 1943 a Olgiate Comasco, forse in un tentativo di fuga in Svizzera. Venne internata nel campo di Fossoli, da dove, il 21 febbraio 1944, in una lettera al Ministero dell’Interno tentò di far valere la sua “arianità ex madre”, chiedendo un supplemento d’indagine sulla sua condizione razziale in base a nuovi documenti probatori, e supplicando che intanto fosse sospeso nei suoi confronti “ogni provvedimento di trasferimento”. La richiesta fece il suo corso, e dalla Questura di Padova il 16 marzo giunse la risposta: non risultando all’anagrafe la sua legittimazione da parte della madre, Ester Giovanna doveva essere considerata “di razza ebraica” e non “mista”, né tantomeno “ariana”. Non sarebbe dunque stata liberata. Ma a quella data il tragico epilogo si era già compiuto. Il 22 febbraio, il giorno dopo aver consegnato la sua istanza al direttore del campo, Ester Giovanna Colombo era già stata caricata sul convoglio n.8 diretto ad Auschwitz, lo stesso in cui si trovava anche Primo Levi. Non sopravvisse.

QUI ABITAVA
GUIDO USIGLI
NATO 1873
ARRESTATO 30.7.1944
DEPORTATO
AUSCHWITZ
ASSASSINATO 6.8.1944
Guido Usigli, nato a Padova l’8 luglio 1873, abitava in via S. Martino e Solferino 30. Viveva solo. Era di condizioni economiche modeste, di professione aveva fatto l’usciere, ma, forse avendo perduto il posto in seguito alle leggi razziali, risulta, al momento dell’arresto, cameriere. Fu arrestato la prima volta nella sua abitazione da due agenti di P.S., nel pomeriggio del 4 dicembre 1943 ed internato nel campo di Vo’ il giorno successivo. Fu dimesso dopo una settimana, perché “di anni 70”, in base alla circolare del 10 dicembre che disponeva il rilascio di ebrei ultrasettantenni, o gravemente malati o di “razza mista”. Tornato in libertà sotto vigilanza, fu arrestato nuovamente dalla polizia tedesca nella retata del 30 luglio 1944. Il campo di concentramento provinciale di Vo’ era stato chiuso il 17 luglio, e Guido Usigli fu incarcerato a Verona e da lì, il 2 agosto 1944, fu deportato ad Auschwitz sul convoglio n. 14. Fu ucciso all’arrivo, il 6 agosto.
Via delle Piazze
Celina Trieste, nata a Padovail 20 settembre 1906, viveva con il padre Moisè Eugenio, anziano e infermo, in una casa di corso Vittorio Emanuele 110, prospiciente Piazzale S. Croce (allora rinominato piazza Italo Balbo), con intorno il grande e magnifico parco disegnato da Jappelli, che, requisito alla famiglia dalle leggi razziali e lasciato in abbandono, fu subito dopo la guerra definitivamente espropriato e distrutto per far posto al quartiere di Città Giardino. La casa e il Parco Trieste erano stati, dal 1938, importante punto di riferimento per gli studenti della scuola ebraica, che lì si trovavano per i doposcuola organizzati da Celina Trieste, con i laboratori di lavoro manuale e di arte, sotto la guida di Tono Zancanaro, di cui Celina era amica. Donna colta e attiva, Celina aveva studiato al Tito Livio e negli anni del liceo era stata compagna di classe di Mario Todesco, divenuto poi professore dello stesso liceo, ucciso dai fascisti nel luglio del 1944, medaglia d’oro al valore civile della Resistenza. Celina si era laureata nel 1932 in Lettere con indirizzo linguistico all’Università di Padova. Nell’ottobre del 1943, quando tutti gli ebrei furono costretti alla fuga o alla ricerca di un nascondiglio, Celina trovò rifugio prima presso l’ospedale psichiatrico di Padova, e poi in quello di S. Clemente a Venezia. Da lì il 6 ottobre fu prelevata dai tedeschi con altri cinque ricoverati ebrei, e portata a Trieste, alla Risiera di S. Sabba. Lì, dichiarandosi non in grado di sopportare il viaggio di deportazione, fu uccisa alla fine di ottobre.


Piazza del Santo, angolo Via Orto Botanico
LA VICENDA DI PADRE CORTESE
La cattura: Padova, 8 ottobre 1944
Quel che doveva succedere e al quale padre Placido Cortese s’era da tempo preparato, un giorno succede. Avvisaglie sul precipitare degli eventi non erano mancate, come l’irrompere nel convento del Santo, che all’epoca era considerato extra territoriale, di agenti della SS tedesca e un primo arresto di Padre Cortese, subito liberato per l’intervento del Superiore provinciale, che si era appellato all’extraterritorialità della basilica, di proprietà della Santa Sede.
Ma nessun può far niente l’8 ottobre 1944, quando i tedeschi, con l’inganno, riescono a farlo uscire dal territorio pontificio e a prenderlo.
La trappola è ben congegnata, e tiene in conto tutto, anche l’extraterritorialità. È una domenica, verso le 13.30. Due tedeschi chiedono di parlare con padre Cortese – “il Padre che si occupa dell’aiuto alle persone bisognose”, dicono alla guardia della basilica -, ma lo aspettano al di là del muricciolo che segna il limite del territorio pontificio. Avvisato di ciò, padre Placido, non sospettando di nulla, si avvia verso l’uscita, attraversando il chiostro della Magnolia. Uno dei due è Fritz Werdnik, sottufficiale di origine slovena, un nazista d’anteguerra, infiltrato nei gruppi di resistenza. Ha un segno di riconoscimento inconfondibile: gli manca un braccio, perduto in Russia, fra le truppe scelte della divisione Brandenburg.
Padre Placido non avverte il pericolo; chi vuole prenderlo ha saputo colpirlo nel suo punto debole: il prodigarsi per chi ne ha bisogno!
In verità il portinaio, fra Stanislao Masetto, allertato dal volto poco rassicurante dei due individui, tenta di dissuaderlo dall’incontrarli. “Non vada, padre – lo prega -. Quei due non mi piacciono”. E lui: “Stanislao, cosa vuoi farci? Bisogna usare carità con tutti. Bisogna che vada, ormai mi hanno visto”. Detto questo, padre Placido va incontro al suo destino.
A muoverlo è ancora una volta l’amore del prossimo, il motore segreto della sua attività.
Fra Stanislao, testimone di quegli ultimi fatidici momenti, racconterà di avere attraversato con lui il sagrato della basilica fino al muricciolo di confine. “Oltre quello spazio – ricorda – c’erano due tedeschi che lo stavano aspettando. Appena il padre varcò il limite, entrando in territorio italiano, i tedeschi lo afferrarono e lo caricarono in macchina. In fretta chiusero le porte e la macchina partì. Padre Placido mi fece un segno di saluto, ma subito un tedesco gli abbassò la mano e io compresi che per lui era la fine”.
La macchina infila sgommando via Orto botanico e da quel momento e per molti anni di padre Cortese si perdono le tracce.
Solo dopo molto tempo si saprà che, in quel preciso momento, era iniziata la “passione” di padre Placido Cortese.


La morte: Trieste, Piazza Oberdan, sede della Gestapo, novembre 1944
Gli aguzzini della polizia segreta nazista infieriscono con bieca ferocia su padre Placido. Quanto rivelato dalle spie infiltrate e da loro stessi appurato sul campo, li ha convinti che il frate è un ganglio importante della rete di salvezza “Fra-Ma”, in stretto contatto con alcuni membri della rete slovena, delle quali di certo conosce molte cose: capi, collaboratori, progetti, trame, percorsi. Cavargli di bocca alcuni nomi che contano servirebbe a svuotare i covi di quei sovversivi. E ci provano subito, prima con le “buone”, probabilmente, seguendo tecniche specifiche in cui sono ferratissimi. Poiché dalla bocca cucita del frate non esce un solo nome, passano alle “cattive” sfoderando il peggio di cui sono capaci, in un crescendo di brutale crudeltà da non risparmiare un solo centimetro del suo corpo martoriato.
Chi l’ha visto in quei giorni racconta di mani spezzate, di bastonate e altre “raffinate” torture cui è sottoposto di giorno e di notte. Ai brutali trattamenti che gli riservano gli aguzzini della Gestapo, lui risponde con un ostinato e totale silenzio: neppure un nome dei suoi collaboratori esce dalla sua bocca.
Sconfitti, lo ributtano in un’orrida cella, buia e umida, lasciandolo al suo ormai inesorabile destino. Da quella cella gli altri prigionieri trattenuti nel bunker di piazza Oberdan sentiranno uscire una continua, sommessa preghiera, notte e giorno.
Sarà un colpo d’arma da fuoco a mettere fine alle sue sofferenze. È il sergente britannico Ernest Barker a fornire questa informazione, nella dichiarazione resa davanti alla Procura militare del suo paese, dopo la fine della guerra. Nel descrivere la propria detenzione a Trieste, oltre ad illustrare le condizioni dei prigionieri, afferma di aver conosciuto un sacerdote proveniente dalla basilica del Santo a Padova e di aver visto i pesantissimi maltrattamenti a cui veniva sottoposto. Pur non conoscendone il nome, non ci sono dubbi che si tratti di padre Placido Cortese. Queste le sue parole: “Io stesso ho visto molti prigionieri, croati, italiani e di altra nazionalità, che sono stati maltrattati (…). C’è stato in particolare un prete italiano, il parroco della chiesa di S. Antonio a Padova, al quale avevano strappato le unghie, spezzato le braccia, bruciato i capelli e che portava sul suo corpo i segni di ripetute fustigazioni. Mi fu detto in seguito che gli avevano sparato”.
Padre Placido si consuma così, nel dolore fisico e nella solitudine.
Intanto i suoi aguzzini si preparano a cancellare ogni traccia di lui, gettando il suo corpo nel forno crematorio della Risiera di San Sabba.
Padre Placido finisce torturato a morte per non aver tradito i compagni con i quali ha condiviso una forte esperienza di carità, mettendo ogni giorno a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Testimoniando così i valori dell’amore, della solidarietà, della fraternità e della pace.
Egli è martire della carità, come il confratello polacco padre Massimiliano Kolbe lasciato morire di fame in un bunker di Auschwitz, per aver voluto sostituire un padre di famiglia.
Una simile fine Padre Placido l’aveva prevista in un suo scritto giovanile: “La Religione è un peso che non ci si stanca mai di portare, ma che sempre più innamora l’anima verso maggiori sacrifici (…), fino a morire tra i tormenti, come i martiri” (Lettera ai familiari, 7 ottobre 1924, tre giorni prima della professione dei voti religiosi a Padova, nella basilica del Santo)


Venezia, 22 gennaio 2021